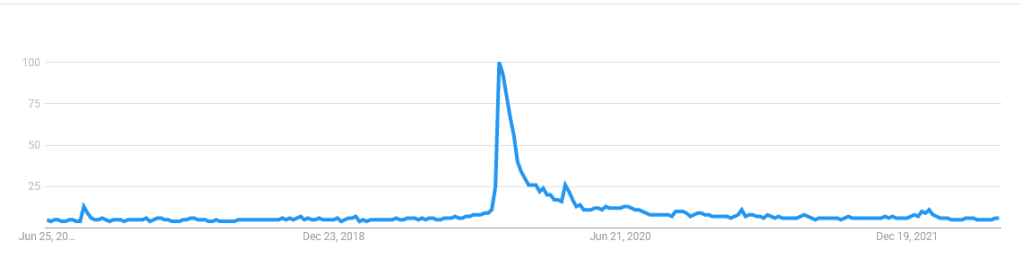Da quando è iniziata la guerra parlarne è diventato una sorta di esercizio terapeutico in cui, in un simbolico lettino da psicoanalista, si cerca di capire come possa essere successa una cosa che era stata bandita dalla nostra agenda sociale. Essendo disabituati all’idea stessa di guerra, il modo in cui si affronta quotidianamente l’argomento in ogni mezzo di informazione non è basato sulla lucida analisi dei fatti (nei limiti dell’oggettività possibile) ma sull’onda di un’emotività che, seppur comprensibile i primi giorni, è diventata ormai perenne. Così il dibattito, e viste le circostanze diventa difficile definirlo tale, non è di fatto progredito di una virgola.
Infatti l’opinione pubblica (rimaniamo su quella italiana, per una banale questione di prossimità) ha prodotto una serie di mantra che, per definizione, vengono ripetuti costantemente e quotidianamente in ogni mezzo di informazione. Il fenomeno è interessante ed ha molte analogie con il come si è parlato di Covid, all’epoca. Grosso modo, le stesse parole, a seconda dell’intonazione con cui vengono dette o cambiando la posizione dei lemmi, creano opinioni divergenti in base a chi le proferisce. E sono opinioni scolpite nella roccia, che guai a cambiarle col mutare delle circostanze. Ma facciamo un elenco, sennò non si capisce.
“Non bisogna far arrabbiare Putin” (a volte sottinteso “Sennò usa l’atomica“). La Russia ha iniziato la guerra. La Russia ha l’atomica. Ergo, meglio non disturbarla mentre fa la guerra perché sennò si arrabbia di più e fa cose di cui potremmo pentirci tutti. Un po’ come il bullo che ti ruba la merenda: è proprio il caso di reagire quando lui, seppur nel torto, potrebbe farci qualcosa di peggio, tipo picchiarci? Nel glossario della guerra fredda esisteva un concetto il cui acronimo era MAD (Mutual Assured Destruction). In breve, se io uso l’atomica va a finire che la usi anche tu. Quindi nessuno vince quando siamo entrambi ridotti a un cumulo di macerie radioattive. Era l’equilibrio del terrore, ed ha funzionato piuttosto bene finora. Le cose cambiano quando si rovescia il concetto: visto che io ho l’atomica e non ho paura di usarla non devi interferire in quello che faccio, sennò la uso. Il problema è che così dall’equilibrio si passa al ricatto. Il fatto è che questo cambio di paradigma porta al gioco del pollo: se si ricorda alla Russia che, alla fine, non è l’unica ad avere armi atomiche allora si corre il rischio di usarle davvero, mentre se si fa finta di non averle allora si legittima la prepotenza di minacciarne l’uso a seconda dei propri capricci.
“Non si parla più di negoziare” (o con la variante “La diplomazia ha fallito“). Prima di iniziare una guerra si avanzano delle richieste. Tuttavia a volte queste richieste sono così manifestatamente irrealizzabili che diventano un mero pretesto. Ad ogni modo, le richieste che vengono avanzate schierando l’esercito al confine di un paese prendono la forma di un ultimatum. Intendiamoci, erano passati otto anni dalla silenziosa guerra di Crimea e Donbass e, eccetto qualche blanda condanna e sanzione, si era fatta la figura degli struzzi. In quel caso certo, la diplomazia poteva fare di più. Diverso è il contesto attuale. Quali sono gli obiettivi della Russia? Quanto l’Ucraina è disposta a perdere per ottenere la pace? Quando l’esercito russo era a Kiev negoziare per gli ucraini significava perdere tutto il paese. Ora che i russi sono impegnati a consolidare il Donbass, negoziare significa perdere solo quella parte di paese, di fatto già “persa” dal 2014. Insomma, il negoziare non è questione di stringersi la mano e amici come prima. Qualcuno deve rinunciare a qualcosa in un determinato momento, di solito quello più conveniente a una delle parti. E nelle fasi più acute di un conflitto, quando è ancora difficile perdonare le morti e la distruzione, di solito non si negozia, ma ci si vendica.
“La Nato non si è comportata bene” (oppure a mo’ di incipit di quiz logico-deduttivo “Se la Nato non si fosse allargata verso est allora …“). Uno dei pensieri che ha raccolto più successo in questa storia è stato quello che, in fondo in fondo, la Nato se l’è cercata. Cosa notevole, se si pensa che fino a poco fa i membri stessi dell’alleanza non ne capivano più il senso. Ora, sarebbe poco onesto cadere nell’estremo opposto. La storia dell’allargamento della Nato verso est è un fatto. Che però questo sia avvenuto per mettere in difficoltà la Russia (fino a minacciarla territorialmente) è un’opinione. Non è facile tracciare una linea di continuità quando si parla di politica internazionale. Nel modo in cui viene usata, “Nato” è anche un’allegoria che sottindende “Stati Uniti”. Però “Stati Uniti” significa, in parte, “governo degli Stati Uniti” il quale resta in carica quattro anni e, cambiando, cambia alcuni dei suoi obiettivi. Ad esempio quando l’Urss stava per disgregarsi questo non faceva piacere all’allora Presidente Bush senior che preferiva avere un interlocutore unico e intero piuttosto che decine sparsi per l’Europa orientale e l’Asia centrale ognuno con le sue rivendicazioni. Ma poi dopo di lui venne il Presidente Clinton, che invece considerava l’ingresso di questi nuovi paesi nella Nato un modo di consolidare queste nascenti democrazie dell’Est Europa (e perché no, esercitarci anche un’influenza). Questi paesi inoltre, militarmente deboli e politicamente instabili, si sono rivelati di fatto solo un onere per gli Usa che, se necessario, dovrebbero intervenire con uomini e mezzi propri per rendere credibili gli impegni militari che hanno con quasi tutto il mondo.
Intendiamoci, questi pensieri non sono completamente assurdi di per sé. Tradotti dallo sloganese, potrebbero diventare rispettivamente: non umiliare il nemico, risolvi i problemi prima che diventino ingestibili, capisci il senso delle tue alleanze. Anche se possono sembrare consigli che darebbe Sun Tzu, effettivamente certe dinamiche della guerra sono rimaste inalterate fin dalle sue origini. Del resto: la guerra, la guerra non cambia mai. Solo che, come solito, ripetere a pappagallo fatti che si mischiano ad opinioni che vengono sempre raccontati parzialmente e fuori contesto fa perdere la bussola del dibattito, ammesso che esista proprio una bussola. Ma quello che colpisce, a prescindere che sia fatto scientemente o meno, è che si viva in uno stato di negazione della guerra come concetto. Certo, tutti vorremmo un mondo senza guerra. Ma il mondo non si conforma necessariamente a questa volontà e purtroppo, in attesa di una definitiva illuminazione del genere umano, bisogna accettarne l’eventualità. Ritrovare il senso di parlarne, senza la paura di essere additati come guerrafondai o pacefondai, è essenziale per maturare come società.